Possiamo dirlo con certezza: non v’è uomo, sotto qualsivoglia latitudine, che non coltivi l’anelito a un’esistenza improntata alla giustizia; che vuol dire esistenza riscattata dallo squilibrio dell’iniquità e dalla mortificante umiliazione dell’abuso e della disonestà. È lo stesso anelito che attraversa la Scrittura: dal grido che si eleva dalla terra, irrorata dal sangue di Abele (cfr. Gen4,10), sino al verdetto dell’Agnello, i cui giudizi – come si legge in Ap 19,2 – “sono veri e giusti”.
Non è per nulla difficile cogliere l’attualità dell’anelito alla giustizia.
Del resto, chi potrebbe sentire lontane le parole di un Geremia che, al cospetto di un Dio “troppo giusto” – come egli stesso afferma –, si chiede: “Perché le cose degli empi prosperano? Perché tutti i traditori sono tranquilli?” (Ger12,1)? Quasi a dire: com’è possibile sopportare le tante forme di ingiustizia da parte di chi crede in un Dio giusto?
Insomma, chiedere giustizia, desiderare, bramare la giustizia: lo facciamo tutti, ogni giorno. Il Discorso della Montagna, però, conferisce a questo anelito un profilo di urgenza che supera la mera aspettativa di un riscatto: è beato chi ne ha fame e sete, chi ne ha un bisogno primario e ineludibile. Soffermiamoci brevemente su questo bisogno primordiale e lasciamoci provocare dalla sua impellenza dirompente.
Una prima considerazione da fare riguarda l’obiettivo della beatitudine, che è duplice:all’annuncio evangelico di felicità è infatti associato collateralmente un movimento di denuncia che, pur essendo implicito, merita di essere approfondito.C’è qualcuno che non è beato, anche se il discorso di Gesù non lo menziona. A non essere beati sono ovviamente coloro che non operano ciò che è giusto; ma il concetto, detto tra le righe, sarebbe fin troppo evidente. Meno palese è invece che lo siano coloro che il giusto lo fanno poco, a metà; o, come mi pare di poter dire, anzitutto coloro che si accontentano di “farla”, come se fosse davvero possibile essere giusti fino a un certo punto, a comando o a orario: fare, insomma, la giustizia part-time, a tempo determinato.
È un atteggiamento pericoloso: a “fare giustizia” in uno scampolo di presente si finisce infatti per “giustiziare” i germogli del futuro nella nostra stessa vita. La parola del Vangelo, invece, è sorprendente: ad essere oggetto di beatitudine è anzitutto il fatto stesso di anelare alla giustizia, non immediatamente il fatto di “farla”; è questo – un atto di desiderio e di slancio – l’impegno primario che “merita” la felicità e, nella logica del paradosso, la consegue nell’atto stesso di rincorrerla, pregustandola in voto prima di raggiungerla de facto. A tempo indeterminato.
Beati, dunque, sono gli affamati e gli assetati; non ovviamente per lo stato di bisogno, deprecabile in sé, ma per l’anelito a superarlo che esso suppone o provoca.A costoro è promessa la sazietà, ma la beatitudine è anzitutto nella tensione che scaturisce dal vuoto dell’indigenza. Con una differenza sostanziale: chi vi si adagia fa della fame la sua tomba; chi invece solca il vuoto della mancanza a larghe bracciate, proteso verso un orizzonte sperato, voluto, amato, lo raggiungerà, ma prima ancora, proprio nel tendervi, è beato.
Il centro è dunque la tensione, lo scarto, il non-detto esplosivo che i due poli – la fame e la sazietà – lasciano intravedere, presupponendo l’atto volitivo (che però è in se stesso dono) del suo superamento. La giustizia non è solo un traguardo, eventualmente raggiungibile per inerzia o per grazia; non è neanche solo un progetto, edificabile con i mattoni della legalità (sicché, ingenuamente, a fare giustizia sarebbe anzitutto e automaticamente il diritto). È un cammino, uno snodarsi di sfide e di possibilità, tra grazia e merito,
un campo complesso in cui germoglia il fiore della beatitudine, preludio di frutti di maturità e di gioia.
Si capisce che sulla strada di questa beatitudine si erge forte una tentazione; è la tentazione adombrata e descritta con fine ironia dal Manzoni quando descrive l’atteggiamento di coloro che “s’adombrano delle virtù come de’ vizi, predicano sempre che la perfezione sta nel mezzo; e il mezzo lo fissan giusto in quel punto dov’essi sono arrivati, e ci stanno comodi”. Ecco, noi rischiamo di fermarci nel mezzo, di saziarci del nostro sentirci “a posto”. Ma Gesù ci dice: beati quelli che non si accontentano, che hanno fame e sete di giustizia, che non si limitano al rispetto formale della legge, che non pensano di essersi meritati quello che hanno.
Ecco allora il rilancio evangelico: non accontentarsi. Come la fame non si sazia una volta per tutte, così è per l’anelito alla giustizia.L’insegnamento è forte ed esigente: non tirare troppo presto i remi in barca; non dismettere l’abito da lavoro per vestire troppo presto quello della festa; non demandare pigramente al dono altrui (provenisse anche da Dio) ciò che l’impegno quotidiano dovrebbe se non guadagnare almeno saper porre in agenda. Perché la giustizia si costruisce, in primis, e poi si chiede. E prima ancora si desidera.
La prassi cristiana ha tanto da interrogarsi: è infatti spesso minata da una subdola forma di assistenzialismo spirituale, che rincorre, come riserva escatologica, il dono di una salvezza che ci si accontenta di invocare, in un’attesa passiva e indolente. La giustizia di molti è senz’altro figlia del “venga il tuo regno, come in cielo così in terra”, ma dimentica l’appello dell’Ascensione: “Perché state a guardare il cielo?” (At 1,11).
Una seconda considerazione, legata al carattere primario del bisogno di giustizia, riguarda la misura del perseguire la giustizia stessa.È sempre urgente operare una misurata distinzione tra giustizia e vendetta, per scongiurare la logica di un giustizialismo che sembra imperversare in molti contesti odierni.In tal senso, dobbiamo ammettere che la massificazione delle comunicazioni globali non aiuta l’odierno spettatore di notiziari e talk show. Il pensante stordimento mediatico non agevola il discernimento tra l’informazione e il suo veicolo, e non di rado accade che la prima venga trasmessa con un (voluto) ricarico emozionale che ne pregiudica la corretta recezione. Dal tam tam delle comunicazioni nascono così orde di indignati che si ergono a giustizieri, fomentati da un’informazione stilizzata e sovraccaricata di stereotipi e di polarità ad effetto.
Davanti a simili banalizzazioni, urge sempre e comunque chiedersi quanto spazio sia davvero riservato alla giustizia nelle sue dimensioni ed esigenze più radicali e profonde. Avere sete della giustizia non vuol dire avere sete di sangue; e questo vale ancor di più se poniamo come orizzonte di riferimento quello biblico. In esso essere giusti significa sostanzialmente allinearsi a Colui le cui vie sono buone e rette. Anelare alla giustizia è anelare a quella rettezza di via che si fa obbedienza, desiderio ardente di ordine e bellezza. La rettitudine del giusto è certamente infiammata dallo zelo, ma si esprime come fame e sete di essere perfetti come perfetto è il Padre dei cieli (cfr. Mt 5,48).
Questo in una prospettiva chiaramente credente. Ma se il termine ultimo sfuggisse?
Che fare se il modello della giustizia (o perfezione) del Padre non fosse immediatamente accessibile, o venisse percepito come di fatto irraggiungibile? Il nostro secolo ne sa qualcosa: in molte sue espressioni ha infatti dismesso l’ideale assoluto per scegliere la frequentazione occasionale di ampie sacche di pragmatismo. Parlare di perfezione e di giustizia può suonare utopico, in un mondo in cui l’imperfezione e la prevaricazione sembrano costituire una norma da cui è difficile derogare.
Ebbene, anche per questo secolo apparentemente così poco sedotto dai grandi orizzonti, anche per questa generazione tanto disincantata, si profila la verità e l’urgenza della promessa di Cristo: beati se avrete fame e sete di giustizia! In questo tempo, anzi, la beatitudine potrebbe trovare un fertile retroterra di autenticità, proprio perché, lungi dalle facili consolazioni, potrebbe ritrovare nella presunta, lancinante “assenza” di Dio il contesto più genuino per cercare una giustizia non pretestuosa. Ce lo suggerisce Simone Weil, la cui audace posizione ci viene sintetizzata con maestria da Maurice Blanchot: “Pensare che Dio esiste è pensarlo ancora presente, è un pensiero alla nostra portata, destinato solo alla nostra consolazione. È più giusto pensare che Dio non esista, bisogna amarlo con tanta purezza da essere indifferenti al fatto che non esista. Per questo motivo l’ateo è più vicino a Dio del credente. L’ateo non crede in Dio: è il primo livello di verità, a condizione che non creda a nessun tipo di dèi. Se avviene questo, se non è in nessun modo idolatra, crederà in Dio in maniera assoluta, anche ignorandolo e attraverso la grazia di questa ignoranza. Non ‘credere’ in Dio. Non sapere niente di Dio. E non amare Dio più della sua assenza, affinché l’amore, essendo in noi rinuncia a Dio stesso, sia amore assolutamente puro e sia quel ‘vuoto che è pienezza’”.
È qui – in quest’assenza che è bisogno, in questo vuoto che è pienezza – lo spazio autentico di una giustizia possibile.Averne fame significa viverne l’attesa. Non come passiva rassegnazione, non come differimento dell’azione e delega di responsabilità (“Verrà un giorno…”, diceva il fra’ Cristoforo di Manzoni). Per quanto questo possa spesso risultare del tutto comprensibile e anzi necessario, attendere la giustizia non significa necessariamente e in prima battuta chiedere a un altro – o magari a un Altro, con la maiuscola – di farla al posto nostro. Significa piuttosto vivere la consapevolezza di doverla cercare. Significa non potersi accontentare dei facili plotoni d’esecuzione (“Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?”, Lc 9,54). Significa, in altri termini, vivere la consapevolezza di doverne scandagliare sempre e comunque, con onerata coscienza, i fondamenti e le motivazioni profonde, persino oltre quelli tradizionalmente legati alla prassi morale più consolidata e, per questo, più consolante.
Abbracciare la giustizia, metabolizzare la giustizia, assimilare la giustizia: questo significa attenderla; questo significa averne fame.Con le parole della Weil: “Bisogna solo aspettare e chiamare. […] Gridare che si ha fame, che si vuole pane. Si griderà più o meno a lungo, ma alla fine si riceverà cibo, e allora non si crederà, si saprà che esiste veramente del pane. Quando non si è mangiato, non è necessario e neanche utile credere nel pane. L’essenziale è sapere che si ha fame”.
E, infine, come assimilare la giustizia? Certamente facendone pane per il nostro sostentamento, sì che divenga stile di vita: uno stile, però, interrogante, prima che uno stato di fatto o di diritto; uno stile che scruti con zelo le anse dell’intimità per rimestarvi il tormento di dover cercare ancora. Contro i simboli tradizionali che la connotano, questa giustizia non sarà imparziale, nonsarà un surrogato di equilibrio e di forza. Solo in età moderna l’immagine della benda sugli occhi della giustizia ha assunto un significato positivo, emblematico dell’imparzialità: un’incisione del 1493 ci mostra che ad apporla è però la Follia, e la cosa, anche al di là della curiosa metafora, dovrebbe farci riflettere. In realtà, nessuna dea bendata dovrebbe governare il cammino del giusto, perché la giustizia ha bisogno di vedere per maturare scelte concrete: le scelte scomode, e a volte estreme, di chi sostenere, amare, servire.
Questa giustizia non è e non può essere generica e astratta. Questa giustizia non cerca di livellare, ma sceglie consapevolmente, e dà prova di scandalosa ma necessaria parzialità. Questa giustizia non ha bisogno di forza, anzi si ritrae per lasciar avanzare l’altro che cresce.
Come altrimenti comprendere alcune provocatorie parabole evangeliche, se non in quest’ottica?
Di una giustizia che vede dobbiamo avere fame e sete, perché essa, per sua natura, lo richiede, non cessando di scrutare – scrupolosamente, persino con acribia e impertinenza – gli anfratti del bisogno, della mancanza, della povertà. Aver fame di chi ha fame, sentire il vuoto per chi è vuoto, cercare chi cerca, chiedere di chi chiede: è questa l’attenzione “famelica”, insaziabile, del giusto.
C’è forse un abisso incolmabile tra questa giustizia e la carità? No, anzi dovremmo dire che per certi versi i due ambiti convergano tanto da identificarsi. Così è, per chi crede, in quel Dio che rivela la sua onnipotenza “soprattutto con la misericordia e il perdono” (Colletta della XXVI Domenica del Tempo ordinario). La stessa tradizione cristiana ha spesso creato divari incolmabili tra giustizia e carità, ignorando che ad essere massimamente esigente non è una giustizia asettica, che si limiti a dare a ciascuno il suo, ma quella giustizia che è pronta a sbilanciarsi senza misura.
Sì, perché la misura della giustizia che si fa carità è il bisogno dell’altro: dunque, almeno potenzialmente, essa è infinita.E almeno potenzialmente è disposta a tutto, anche a divenire obbrobrio, negazione dell’equilibrio, dell’autoconservazione, croce, sacrificio totale.
Il giusto ha fame di questa giustizia, potenzialmente ingiusta agli occhi del mondo, divinamente gravida di follia e di salvezza.
(testo dell’intervento “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati”, pronunciato al Festival dei due mondi, Spoleto, 3 luglio 2015)





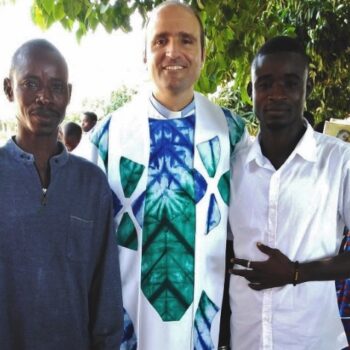









0 commenti